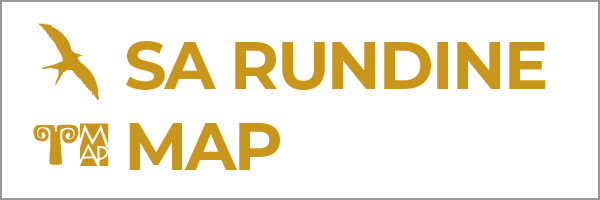IL MAP
Il Museo, inaugurato nel 1988, raccoglie le testimonianze Archeologiche e Paleobotaniche dell’Anglona. L’esposizione si divide in 8 sezioni, organizzate cronologicamente, e 3 allestimenti tematici.
SEZIONE PALEOBOTANICA
Espone una collezione di fossili vegetali provenienti dalle Foreste Pietrificate dell’Anglona, un’area che si estende per oltre 300 km². La formazione risale a circa 18 milioni di anni fa e deve la propria origine all’intensa attività vulcanica e ai fenomeni idrotermali che interessarono la zona. Questi eventi distrussero le antiche foreste, i cui tronchi, immersi nei bacini lacustri, andarono incontro a un processo di fossilizzazione: la lignina del legno fu progressivamente sostituita dai minerali, in particolare dalla silice, dando origine ai fossili oggi visibili.
SEZIONE PALEOLITICA
In questa sezione sono esposti i più antichi manufatti in pietra rinvenuti sinora in Sardegna, datati al Paleolitico Inferiore, circa 450.000 anni fa. Si tratta principalmente di strumenti litici — come lame, raschiatoi e denticolati — realizzati in selce dalle prime comunità umane giunte sull’isola.
L’uomo, durante il Paleolitico, poté raggiungere la Sardegna sfruttando i temporanei collegamenti via terra che si formarono nei periodi più freddi delle glaciazioni, quando il livello del mare si abbassava fino a 120 metri.
SEZIONE MESOLITICA
Il percorso museale accompagna il visitatore dal Paleolitico Inferiore al Mesolitico, periodo compreso tra il 10.000 e il 6.000 a.C., quando lo scioglimento dei ghiacciai dell’ultima era glaciale trasformò profondamente l’ambiente. L’uomo, costretto ad adattarsi alle nuove condizioni, modificò le proprie abitudini: alla caccia affiancò la pesca, sviluppando una nuova tipologia di strumenti, diversi per forma e dimensioni, adatti alle mutate esigenze di vita.
SEZIONE NEOLITICA
L’età Neolitica, sviluppatasi in Sardegna tra il 6000 e il 3500 a.C., segna un periodo di profonde trasformazioni nella vita delle comunità umane. Con la nascita dell’agricoltura e dell’allevamento, i gruppi diventano stanziali e si diffondono nuove attività, come la lavorazione dell’argilla per la produzione di vasellame.
La sezione accoglie interessanti materiali in ceramica e in pietra. Ben rappresentata è anche la Cultura di Ozieri (4000–3500 a.C.), con eleganti esempi di ceramica finemente decorata e dipinta.
ALLESTIMENTO LA GRANDE MADRE
Il sentimento religioso delle comunità preistoriche della Sardegna si manifesta in modo profondo e suggestivo attraverso le statuette femminili raffiguranti la Dea Madre.
In località Sos Badulesos, nelle campagne di Perfugas, è stato rinvenuto da Gavino Muraglia un esemplare unico di statuina della Dea Madre con in braccio un bambino. Nonostante l’usura del tempo e la perdita di una piccola porzione, la statuetta conserva intatta la forza simbolica della maternità e della fecondità.
L’opera appartiene al gruppo delle raffigurazioni volumetriche e naturalistiche che compaiono a partire dal V millennio a.C., testimonianza significativa della spiritualità e della sensibilità artistica delle antiche popolazioni sarde.
SEZIONE ENEOLITICA
Nella successiva età Eneolitica, sviluppatasi tra il 3500 e il 2300 a.C., la scoperta dei metalli segna profondi cambiamenti nella vita dell’uomo, sia sul piano sociale che culturale. Sebbene gli utensili di uso quotidiano continuino a essere realizzati in pietra, il rame — risorsa fondamentale di questo periodo — inizia a essere impiegato per la produzione di attrezzi agricoli e lame, aprendo la strada a nuove tecniche e a un diverso modo di organizzare il lavoro e la società.
SEZIONE NURAGICA
Uno degli aspetti più significativi della storia della Sardegna è la nascita e lo sviluppo della Civiltà Nuragica, che attraverso diverse fasi si estende dal 1800 al 700 a.C. e rappresenta una delle culture più affascinanti e originali dell’intero bacino del Mediterraneo.
Al periodo immediatamente successivo alla Cultura di Bonnanaro (2300–1800 a.C.) risale la progressiva diffusione degli elementi architettonici tipici della civiltà nuragica: i nuraghi, costruzioni a una o più torri spesso circondate da villaggi di capanne circolari, i templi a pozzo, dedicati al culto delle acque, e le Tombe di Giganti, monumentali sepolture collettive caratterizzate da grandi stele frontali in pietra.
Sono qui esposti numerosi reperti che testimoniano la cultura materiale di questo periodo: la ceramica è rappresentata da vasellame di varie forme e funzioni, mentre i manufatti in bronzo comprendono pugnali, fibule e bracciali.
ALLESTIMENTO L’ACQUA E IL SACRO
Il periodo nuragico si distingue per la straordinaria bellezza e imponenza delle sue architetture, che comprendono sia edifici di uso abitativo, sia luoghi di culto strettamente legati al culto delle acque. La particolare cura riservata alla costruzione di questi ultimi testimonia l’importanza che la società nuragica attribuiva agli aspetti religiosi e simbolici dell’acqua.
Tra i più significativi esempi di architettura sacra dell’isola spicca il Pozzo Sacro del Predio Canopoli, situato nel centro abitato di Perfugas. Questo monumento, realizzato in opera isodoma con blocchi di pietra calcarea, è considerato uno dei più importanti esempi di luogo di culto nuragici, insieme a quelli di Santa Cristina a Paulilatino (OR) e di Santa Vittoria a Serri (CA).
Oltre al Pozzo Sacro del Predio Canopoli, l’allestimento comprende anche testimonianze di altri importanti siti della zona, come la Fonte Sacra di Niedda, situata in una proprietà privata nel territorio di Perfugas, e il Pozzo Sacro di Irru, nel comune di Nulvi.
SEZIONE CLASSICA
Dall’800 a.C. la Civiltà Nuragica entra in contatto con le più grandi civiltà del Mediterraneo Orientale e Occidentale come i Fenici, gli Etruschi e i Cartaginesi, la cui presenza stanziale è ben documentata nell’isola. Nel 238 aC., con la definitiva conquista romana della Sardegna, anche il territorio di Perfugas vede una progressiva romanizzazione della cultura. I romani si insediano nella collina di Santa Maria all’interno delle strutture nuragiche già preesistenti, che riutilizzano e ampliano secondo una logica consueta di adattamento dei sistemi e delle tipologie costruttive alla realtà locale preesistente.
I principali siti riutilizzati, per chiare finalità di approvvigionamento idrico, sono stati i due pozzi sacri situati uno a Perfugas (predio Canopoli), l’altro a Nulvi (pozzo sacro del nuraghe Irru).
SEZIONE MEDIEVALE
La parte finale del percorso museale è dedicata al periodo medievale e post medievale, che vede il territorio di Perfugas arricchirsi di chiese, edificate tra il periodo romanico – nel XII e XIII secolo d.C., fino al 1700.
Oltre ai materiali esposti nelle vetrine, relativi rispettivamente ai periodi altomedievale (prima del 1000) e basso medievale, tradizionalmente fino al 1492, risultano di particolare interesse le chiese di Santa Maria della Concezione, Santa Vittoria, San Giorgio, Santa Croce, Santa Maria degli Angeli al cui interno è custodito il bellissimo retablo di San Giorgio del XVI secolo.
ALLESTIMENTO IL TERRITORIO
L’ultima sala è composta da 14 vetrine, che ospitano il terzo ed ultimo allestimento a chiusura del MAP di Perfugas. La mostra permanente “IL TERRITORIO, L’ UOMO, LA MEMORIA” ha come finalità il voler approfondire tutto il lavoro che, dal 1978, la Soprintendenza archeologica delle province di Sassari e Nuoro ha svolto nel ricco territorio Anglonese. 14 vetrine per 12 paesi dell’Anglona: Perfugas, Laerru, Martis, Bulzi, Santa Maria Coghinas, Sedini, Chiaramonti, Tergu, Castelsardo, Valledoria, Erula, e Nulvi, più Viddalba e Badesi, che fanno parte del territorio della Gallura, ognuna dedicata e ricca di materiali molto interessanti. Il discorso, non più cronologico, ma a carattere tematico e topografico, ci offre uno spaccato dell’imponente patrimonio culturale che ogni singolo paese ha conservato gelosamente per migliaia e migliaia di anni.